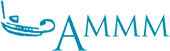|
Domenico Nico
Nome: Domenico Nico Soprannome: Gnormà Nato: 13 Luglio 1929 a San Benedetto del Tronto Figlio di: Nico Saverio e Teresa Maria Pia Del Zompo Professione: funaio
generazioni di funai
La mia vita inizia in viale Colombo, la via parallela al porto. San Benedetto nella prima metà del novecento era molto piccola e tanti spazi erano coperti dalla sabbia e dalle zone paludose. Ma per mio padre e, prima di lui, suo padre e il padre di suo padre, alcuni di questi luoghi erano ambienti di lavoro; i funai, infatti, con le loro ruote e i loro tralicci, per la filatura della canapa, li occupavano per centinaia di metri. Il mio destino fu, quindi, quello di imparare il mestiere di funaio e di continuare a percorrere gli spazi. All'età di quattro - cinque anni mio padre mi portava ovunque lui andasse, perciò mi chiamava “il suo battello”. Ero così magrolino che mi caricava con poco sforzo sopra la canna della sua bicicletta per andare la domenica dagli amici, con i quali si ritrovava al bar dell'hotel Progresso in viale Trieste. Le altre giornate, spesso, le trascorrevo seduto sopra una balla di canapa, ricoperto da vecchie giacche, a guardare babbo mentre pettinava la canapa fino a formare i nocchi. Sì, era un funaio di fino e di grosso che aveva imparato il mestiere da suo padre e da suo nonno, uomini che al tempo dei Borboni si recavano a cavallo in Abruzzo, eludendo gli “sbirri” a cavallo, per andare a commerciare le corde con i pescatori regnicoli. Ricordo ancora quando mi raccontavano le loro storie da contrabbandieri, un po' ingenue e un po' fiere. All'età di sette anni ho iniziato a girare la ruota per aiutare mio padre; ci andavo di pomeriggio dopo la scuola. Un'estate, però, la dovetti trascorrere alle dipendenze di un altro funaio, Gino, era un uomo un po' severo e con le mani pesanti, ma in quel periodo i bambini spesso venivano picchiati, a me non toccò mai, però voleva che durante la sua pennichella pomeridiana lo sventolassi con il giornale per scacciargli le mosche. Inoltre mi faceva andare con il carretto a prendere i fasci di canapa in viale Colombo, senza aiutarmi mai a trascinare quel pesante carico.
I bambini che aiutavano i funai molte volte non andavano a scuola e venivano trattati dai loro padroni come schiavetti, era una consuetudine tacitamente legalizzata per poter sopravvivere. In realtà anche in altri ambienti i bambini lavoravano ma non erano sotto gli sguardi di tutti, perché non lavoravano all'aria aperta, ma erano puniti nello stesso modo, solo che pochi vedevano. Il lavoro che i funai affidavano ai bambini era il più delle volte quello di girare la ruota, un compito molto delicato in quanto se la ruota veniva girata un po' più velocemente, il filo di canapa si stuccava e bisognava ricominciare tutto il processo di torsione del filo. Ciò purtroppo accadeva perché il bambino a stare fermo per ore si stancava e si annoiava così tanto che era facile per lui far divagare la mente con altre fantasie e quando ritornava al compito non sempre prendeva la giusta misura. La punizione corporale era sicura e nel poveretto cresceva la rabbia e la voglia di fuggire. Alcuni bambini infatti resistevano poco e se ne andavano, ma non sempre questo comportamento era accettato dalle famiglie che con altrettanta forza e incomprensione, ma soprattutto per necessità, lo rimandavano a lavorare. Io ero fortunato perché mio padre mi aveva insegnato i trucchi del mestiere, ossia che quando il padrone diceva di diminuire il giro della ruota bisognava quasi farla fermare e poi, al comando successivo, rifarla girare con più lena. In questo modo ho evitato tante volte di stuccare il filo, ma gli altri ragazzi quando gli si chiedeva di rallentare, diminuivano di poco combinando il guaio. Non sempre i ragazzi dovevano portare i loro guadagni alle famiglie, ricordo, infatti, che con la mia prima paga mi comprai un paio di scarpe marca Areoplano. Erano bellissime le più belle che ho indossato.
Quel lavoro estivo comunque me lo meritai in quanto avevo manomesso la pagella; avevo otto anni e il maestro Borri mi mise un'insufficienza che io cancellai, quando se ne accorse chiamò mio padre, che per punizione mi mandò a lavorare.
Da viale Colombo io e la mia famiglia ci trasferimmo in via Legnago e lì trascorsi altri anni della mia infanzia fino a quando non scoppiò la guerra, o meglio, fino al quel fatidico 15 marzo del 1944, un giorno che è ancora stampato nella mia memoria; la mia casa venne letteralmente schiacciata sotto lo scoppio di una bomba, perdemmo tutto, dai mobili alle stoviglie. Purtroppo nessuno ci poté aiutare, ma la provvidenza volle che mio padre aveva ancora un piccolo magazzino in via Fiume, lì abbiamo ricominciato la nostra vita. Avevo quindici anni e volevo andare a studiare al Montani di Fermo, sono stato sempre un bravo studente, ma le necessità familiari me lo impedirono, così iniziai il mestiere di funaio sotto la guida mio padre per quindici anni. Alternavo il lavoro con alcuni momenti di svago che mi concedevo a bordo della barca con la quale andavo a pescare insieme al mio amico Rosetti, esperto marinaio. Un giorno andammo a pescare nei pressi della foce del fiume Tronto e il carpasogliole si incagliò sui resti del Tasso, una nave della marina borbonica, attualmente è ancora incagliata nel fondo del mare.
la svolta
Nel 1958 si diffusero le fibre sintetiche e il mestiere di funaio ha subìto un immediato stravolgimento. Molti funai si sono sentiti persi, infatti alcuni hanno cominciato ad emigrare per trovare lavoro, altri si sono adattati, con gran fatica, a lavorare le fibre sintetiche che è ben altra cosa che lavorare la canapa. Mio fratello, ad esempio, si trasferì a Milano per imparare il nuovo mestiere. Io volli andare in Germania, ma l'impatto con questa nazione fu bruttissimo. Durante il viaggio di andata il controllore del treno mi accusò che non ero in regola tanto che dovetti scendere. Quella volta toccai con mano che cosa significa essere razzisti e ora quando sento di tutta quella povera gente che sbarca in Italia con i barconi per trovare un po' di lavoro, penso al mio passato. Quando riuscii a riprendere il treno perché aiutato da un ragazzo tedesco che prese le mie difese pensai di andare a Colonia per lavorare con la Ford, ma trovai i cancelli chiusi perché era sabato, avevo con me solo pochi soldi e quindi decisi di riprendere un altro treno e di ritornare a casa. Ritornato a casa chiesi a mio padre un prestito di 10 mila lire per andare in Ascoli e iscrivermi alla camera dell'artigianato con l'intento di mettermi in proprio, del resto il mestiere lo conoscevo, dovevo solo cambiare la materia prima. Ottenuto il permesso mi misi a cercare sulle pagine gialle i numeri di tutte le ditte in Italia che si occupavano di demolizione di barche e trovai una ditta di Triste che aveva 200 quintali di Manilla, una fibra vegetale ormai introvabile a San Benedetto, ma ottima per la lavorazione dei cavi misti. Il padrone della ditta la vendeva a 100 lire al chilo. Non disponevo di quella cifra che ammontava a quasi due milioni di lire, allora andai a chiedere in banca un prestito; anche in questa situazione la provvidenza mi aiutò perché il direttore di banca ripose molta fiducia su di me, anche se non gli davo nessuna garanzia e mi concesse il prestito. Arrivato a Trieste vidi queste corde di Manilla tutta sporca e troppo sottile ma ormai c'ero e decisi di prenderla, la caricai su un camion di fortuna e giù fino a casa animato da una forte speranza e nello stesso tempo pieno di timori. Giunto a San Benedetto in molti vennero a sapere del mio carico e così ebbi numerose richieste; vendetti la metà e con il ricavato potei subito estinguere il debito, mentre con l'altra metà iniziai la mia attività in proprio. Era il 1960.
Nel 1958 la canapa venne sostituita dalle fibre sintetiche per la lavorazione del cordame da rete, mentre per i cavi da traino venne utilizzato l'acciaio. A San Benedetto, però,in quegli anni ancora nessuno produceva cavi d'acciaio, infatti venivano comprati nelle aziende specializzate di Milano. Questa situazione cambiò quando il professor Ciabattoni, insegnante nella scuola di avviamento marinaro, organizzò una gita scolastica a Sesto San Giovanni (Milano) in una fabbrica di cavi d'acciaio, spingendo i suoi studenti a fotografare tutti i macchinari della fabbrica e i passaggi di produzione. Ritornati nella cittadina adriatica, con tutto il materiale cartaceo, il professore lo sottopose all'attenzione scrupolosa di un abile perito meccanico, Artemio Cicconi, il quale riprodusse, nella sua officina, le macchine per la fabbricazione dei cavi d'acciaio che i ragazzi avevano fotografato. Da questa azione di spionaggio industriale il professor Ciabattoni , insieme ad un socio fondò la ISCAF, la prima fabbrica a San Benedetto di cavi d'acciaio.
Lavorai per altri quindici anni in un luogo bellissimo: il porto. Nel frattempo misi su famiglia, infatti ho due figli maschi che con mia grande soddisfazione si sono laureati. Un grazie lo devo dire anche a mia moglie la quale mi ha aiutato molto, infatti, mentre io mi occupavo di cavi lei realizzava a mano (perché mai ha voluto usare le macchine) le reti per le porte utilizzate nello sport del calcio. Un mestiere che mi sono inventato in un momento di crisi e che mi ha fruttato abbondanti guadagni. Un giorno, nella mia fabbrichetta al porto, venne un rappresentante che vendeva il filo d'acciaio inox, non utilizzabile per i cavi in quanto troppo tenero, al quale dissi che non potevo acquistarlo. Passarono due anni e un giorno mi chiamò la segretaria di una ditta di Bologna che commerciava con la Scoda, che, attraverso il marito, mi aveva conosciuto e che aveva bisogno di 50 milioni di funi molto sottili per alcuni componenti elettrici. Quell'occasione mi fruttò così tanti guadagni che mi permisi di ingrandire la mia attività. Infatti decisi di comprare un capannone ad Acquaviva. Con il tempo presi altre fortunate commesse che mi permisero l'acquisto di altri macchinari. Dal 1993 al 2007 iniziai a produrre i cavi d'acciaio finalizzati al sollevamento carichi e alle teleferiche. Avevo clienti sia marchigiani che sparsi per l'Italia, molti in Emilia e in Toscana. Ero un artigiano che realizzava prodotti di altissima qualità, difatti prima di fare una fune mi facevo spiegare dal cliente a cosa gli serviva e poi gliela fabbricavo adatta a quella funzione. Inoltre lavoravo onestamente e ciò mi ha sempre ripagato. Ricordo un caro cliente di Fano, un armatore, che non voleva pagare con le cambiali ma solo con soldi liquidi. Un giorno vado a Fano e mi dicono che Erminio, il mio cliente, è morto: mi doveva dare dei soldi ma non osai andare dalla vedova a chiederli, così aspettai quindici giorni. Poi ritornai a Fano dalla moglie, la quale mi disse che mi aspettava perché il marito aveva lasciato in un cassetto un rotolo di soldi proprio per me.
orto e lavoro
Per quarantacinque anni ho sempre lavorato da solo, tutti i giorni anche la domenica e la sera dopo cena, ho sacrificato molto la mia vita, la mia salute e quella di tutta la famiglia, ma il lavoro mi piaceva e non mi pesava. Avevo vicino al capannone un piccolo orticello che mi ha dato tanta soddisfazione. La mia fabbrica era piccola ma piena di verde intorno perché volevo che diventasse anche un ricovero per gli animali, soprattutto d'inverno. Ho lavorato fino all'età di settantotto anni, poi ho dovuto smettere perché più volte mi resi conto che i miei riflessi cominciavano a cedere e quindi il lavoro poteva diventare pericoloso. Tuttavia continuo a fare la rete sportiva, infatti l'ho promessa ai ragazzi del liceo scientifico.
San Benedetto è molto cambiata da quando sono nato io, non solo urbanisticamente, ma soprattutto culturalmente. La mia generazione era povera tuttavia conosceva bene il verbo “dare” e “essere”, ora mi sembra che nella mia città si conosca solo il verbo “avere”.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENZIONE
Il materiale contenuto in queste pagine è soggetto a copyright.
Per utilizzarlo è necessario ottenere il preventivo consenso.
Viale Colombo n. 94
63074 San Benedetto del Tronto - AP - Italia
cell. +39 353 4109069
tel. +39 0735 592177